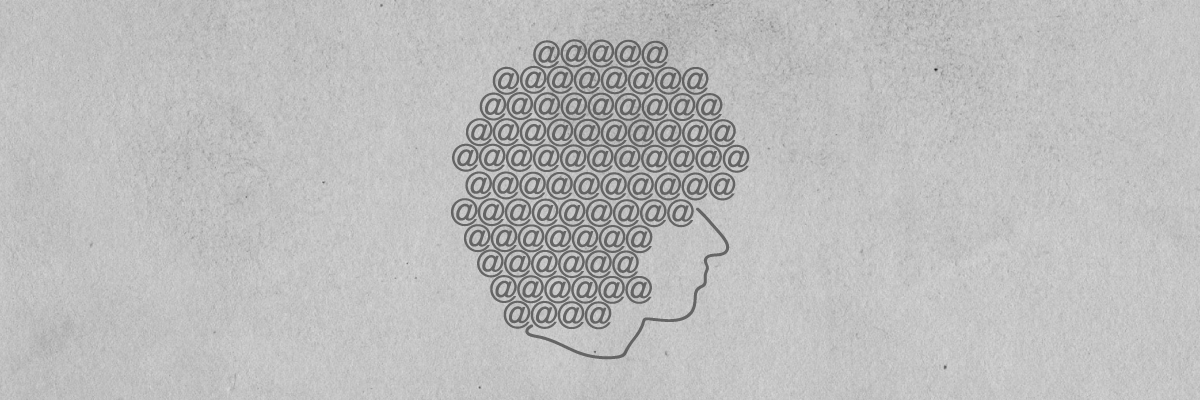Credo che ogni città abbia con sé una certa magia, un’intensa bellezza che può nascondersi in cose anche banali, è solo questione di trovarle. Mica c’è bisogno di un monumento, una torre, la barriera corallina o cose del genere. Quelle sono altre cose. Io parlo di quello che c’è per le strade, i negozi, le luci, i neon, i profumi, cose così. Mi ricordo quando qualche anno fa alle 5 del mattino rientravo in albergo passeggiando tra le vie di Milano, e ho visto una delle albe più intense della mia vita. Cioè, sono abituato a veder sorgere il sole dal mare – e questo la dice lunga – ma quella mattina li, tra i palazzi annoiati di Milano, c’era una costellazione di colori straordinari che sfondavano le strade, e tutto era, incredibilmente, lilla e perla. E mi viene in mente quel paese sperduto ai confini di Londra, Swan Place, due strade che s’incrociano e decine di negozi di fiori, un laghetto con i cigni che danzano silenziosi, un caffè con dei muffin fatti in casa, l’odore caldo del cioccolato fuso. Questa magia qui.
Non ho mai creduto di riuscire a trovare meraviglie del genere anche in città apparentemente fredde e mute, come Pesaro, che per certe cose mi ha sempre lasciato indifferente alla sue nebbie ed i suoi silenzi. Viverci così, però, qualche giorno alla settimana, mi ha cambiato il modo di vedere le cose e insegnato ad usare tutti e cinque i sensi, cosa che prima non mi era capitato mai. Pesaro e l’odore di cipolla all’ora di pranzo per le vie del corso, si sente solo odore di cipolla, non ne si capisce il motivo. Non è nemmeno un granché per chi come me la odia, ma la cosa mi fa quasi sorridere. Il mare invece, a Pesaro, credo sia molto più salato, o qualcosa del genere, perché al porto e sulla spiaggia lo senti conficcarsi nelle tue narici e ti rimane li per ore, quel calore bianco salato. E come ti allontani dalla spiaggia arriva quello di cipolla, e basta. Mare e cipolla, pazzesco.
Pesaro è ferma, muta, silenziosa, a volte sembra che non ci viva nessuno. Bisogna toccarla per sentire che effettivamente c’è. E se si trova gente lungo il corso, o una fiera nella piazza del centro, vige sempre una certa calma, un preciso equilibrio che non ho mai visto spezzarsi. Ma la cosa più bella è che ci sono decine e decine di librerie. I libri. Ci sono ancora persone, a migliaia direi, che amano comprare libri e toccare la carta nuova con l’odore di fresco tra le pagine ed il sapore giallognolo delle librerie. Se a Swan Place ad ogni cinquanta metri ci trovi un negozio di fiori, nel cuore di Pesaro ad ogni dieci passi ci trovi una libreria.
Questa cosa delle librerie mi fa pensare a quanto cavolo debbano leggere i pesaresi. Quanto tempo debbano trovare, nella loro vita, per leggere. Come se le persone si riprendessero il proprio tempo. Penso a tutte quelle pagine sfogliate, alle dita che scivolano sulle parole e sulle copertine, e tutto quello scrivere che attraversa le persone, al fermare la frenesia e squarciare la nebbia, con i libri. Sembra una cosa da niente, ma se invece ci pensiamo proprio bene è qualcosa di grandioso. È un’armonia, un ritrovare sé stessi. Ritrovarsi in una città che forse ha la forza di rompere la velocità e i rumori. Gli unici suoni che si elevano sul sottofondo della quotidianità sono le note che trapelano dal conservatorio Rossini, una gran confusione a dirla tutta, di fiati ottoni e voci.
È un’atmosfera inquieta e ansiosa, certe volte. Non è facile capirla, Pesaro. Ci sono ancora alcuni conti che non mi tornano, come ad esempio dove cavolo vadano le persone la sera, o come facciano (quelle poche che passeggiano) a non far rumore. Non c’è nemmeno il McDonald’s, forse si sono dimenticati di Pesaro anche loro. Forse se ne sono dimenticati in tanti. Forse sono in tanti che si sono dimenticati di leggere. E di usare tutti e cinque i sensi quando si cammina per le vie di una città. Sembra che stiamo accusando problemi di percezione, del sentire come i posti vivono, e come noi viviamo mentre attraversiamo le strade e i corsi del centro.
Non lo so di preciso che diamine stia accadendo, quando tutto cambierà magari avrò più chiara la questione. Perché solo quando le cose cambiano si capisce cos’è che davvero viene a mancare. Forse è per questo che Pesaro è immobile, e zitta, credo che non voglia cambiare mai, per non perdersi.
Ieri stavo passeggiando sulla spiaggia, mano nella mano con Angelica, per un istante ho lasciato la presa, mi sono abbassato per raccogliere una conchiglia e m’è sembrato come se stessi raccogliendo la mia anima.