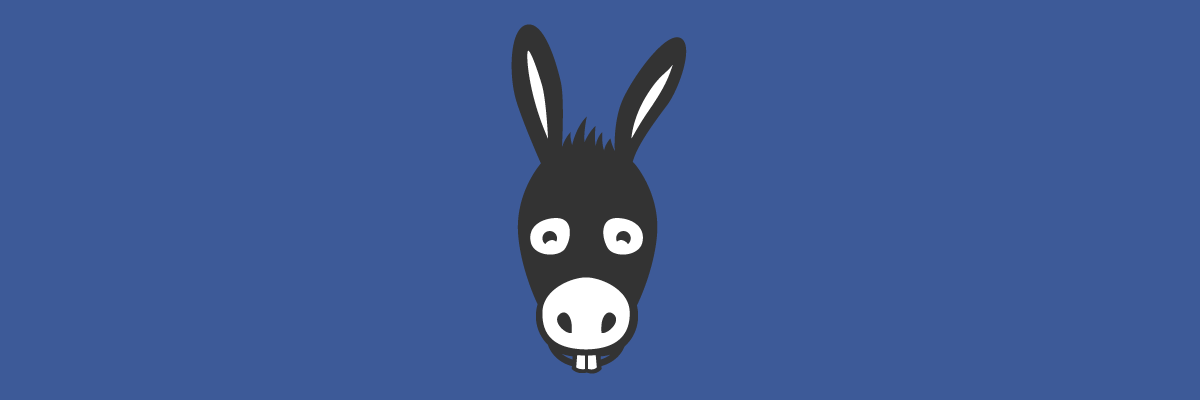Esistono un sacco di regole per tirare a canestro. Per tirare bene. Che poi ognuno le personalizza a modo suo, si, ma grossomodo tutto si riduce ad una serie di gesti, movimenti e tanta concentrazione. Precisione.
A qualcuno viene naturale, così, prendere la palla in mano e fare canestro senza sapere nulla di tecnica e postura. Nessuna sbavatura, senza neppure toccare il cerchio. Quei tiri che senti unicamente il “flap” della palla in rete. Flap.
Quello è il talento. Potrebbe anche essere una grandissima botta di culo, ma nel 99% dei casi è talento, eccome.
Se ci spostiamo dal campo di pallacanestro a quello della pubblicità, quel centro perfetto, flap, quel tipo di talento, diventa una grande idea.
Una grande idea può venire a chiunque, magari anche per culo. Ma se sono due, tre, dieci o ancora di più, allora chiamale come ti pare ma non è questione di fortuna, non è culo, è talento.
Poi ad un certo punto le idee da sole non bastano più. Sul campo da gioco si incontrano avversari bravi a difendere il canestro e ad oscurarti la visuale, il cerchio non lo vedi più, e anche se non ci capisci niente di postura e tiro hai bisogno di guardare il cerchio, altrimenti dove cavolo tiri. Non è una domanda, dove cavolo tiri.
Questa situazione è parte del gioco della pallacanestro, magari il cerchio non lo vedi sempre, o non lo metti a fuoco come vorresti, ma c’è il tabellone.
Il tabellone è la pubblicità.
Oh si, grande e rettangolare, lo vedi di sicuro appena ne hai bisogno. Ed è molto probabile che da qualunque punto del campo, soprattutto sottorete, quando la prospettiva si fa verticale e i difensori avanti a te coprono spiragli e speranze, è molto probabile che tu veda almeno un angolo del quadrato disegnato dentro al tabellone.
Per una legge affascinante e geometrica, quando ti trovi particolarmente vicino al canestro e lanci la palla all’interno del quadrato, è molto, molto probabile che la palla finisca in rete. Non sarà più un centro perfetto, ma un canestro di sponda, furbo. Niente flap, ma rumori di rimbalzo contro diversi materiali tra cui il ferro del cerchio.
Quindi, se il tabellone è la pubblicità, allora il quadrato del tabellone è il marketing. Non è una cosa che puoi insegnare all’università, no, ma se dovessi spiegare nel modo più semplice cos’è il marketing ad una persona che non ne vuole sapere di inglesismi e paroloni complicati, ecco, a questa persona direi che
il marketing è il quadrato del tabellone da basket.
In una partita di pallacanestro non puoi permetterti di puntare esclusivamente sull’abilità di compiere decine e decine di centri perfetti, è come pensare di cavartela nel mondo della comunicazione solo con delle buone idee.
Per vincere serve sinergia tra il talento e la strategia. Canestri perfetti e altri di rimbalzo contro il tabellone. Questo serve. E anche il gioco di squadra, ovviamente.