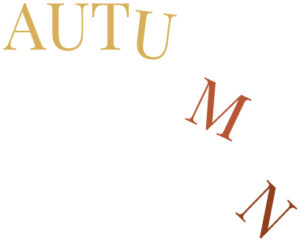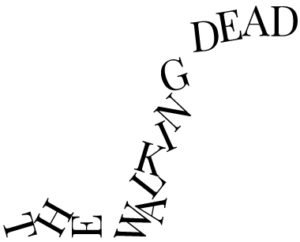Ti dico una cosa, lo faccio con un dispiacere nell’anima, davvero: gli inventori sono gente di altri tempi. Gente sempre fuori luogo, insoddisfatta per natura, ambiziosa, gente di altra pasta e altri posti.
Devi metterti in testa che gli inventori non esistono più. Oggi ci sono gli ingegneri, i designer, i progettisti. Si, c’erano anche una volta, ma oggi la loro figura professionale ha guadagnato terreno ed importanza, togliendone, come ti dicevo, agli inventori. Apparentemente la differenza è sottile, anche i dizionari faticano a scandire bene il ruolo di uno e dell’altro. Beh, te la spiego io questa faccenda che, ti assicuro, è molto più romantica e lungimirante di quanto si possa immaginare.
La differenza tra inventori e ingegneri
Gli inventori sono ossessionati dall’esigenza di creare cose che non esistono e che migliorano la vita, anche in modo assurdo. Hanno inventato oggetti geniali come la cannuccia e il cavatappi, tu ora dirai che sono cavolate ma prova a pensare ad un mondo senza cannucce e cavatappi. Capisci di cosa parlo? Hanno trascorso l’intera esistenza a semplificare la vita di noi coglioni. La radio, per esempio, quasi abbiamo smesso di ascoltarla, se non quando siamo al volante o in un centro commerciale. Ma hai idea di quanto genio serva per concepire un apparecchio del genere? Non costruire ma concepire. Non solo la radio, pensa alla tastiera dalla quale stai scrivendo, ti sei mai chiesto perché i tasti sono disposti in quel modo? Lo sai perché iniziano con la Q e non con la A? C’è stato un tizio, un certo Christopher Sholes, inventore, che ha brevettato un nuovo modo di disporre le lettere: lo ha chiamato QWERTY, come le prime sei consonanti che trovi sulla tastiera, e ha permesso a chiunque di battere a mano più velocemente evitando che s’inceppassero i merletti della macchina per scrivere. Sholes ha fatto tutto questo nel 1864, ascolta bene, milleottocentosessantaquattro. Non c’erano ancora le penne a sfera.
Per inventare queste cose serve un certo genio. Una sorta di follia che non ha niente a che fare con la visione progettistica, di certo affascinante, degli ingegneri che hanno costruito veicoli per andare sulla Luna. Vedi, anche le astronavi spaziali sono invenzioni, ci mancherebbe, ma appartengono ad una categoria differente, dove la scienza si evolve di pari passo con la creatività. Tali invenzioni sono proprie, come ti dicevo, degli ingegneri, dei progettisti, talvolta dei designer. Un inventore non costruirebbe mai una navicella spaziale. Si impegnerebbe, piuttosto, nell’invenzione di una macchina volante, capisci dove sta la differenza?
Gli inventori si riuniscono nei club degli inventori, o almeno così facevamo fino a quando esistevano (entrambi). Oggi quanti ne conosci? Quanti ne hai visti? Nessuno, perché loro non ci sono più, si sono portati nella tomba anche la parola stessa: inventore. Non la trovi bellissima?
Se dovessi darti una definizione più precisa di quella che trovi sul dizionario, ti direi questo:
l’inventore inventa per il gusto, il gesto e la passione di creare cose che ancora non esistono fisicamente. Queste cose lui le vede prima che qualcuno ne senta l’esigenza. Le inventa prima che chiunque si possa chiedere come migliorare la vita quotidiana. L’inventore inventa oggetti e marchingegni incredibili per dimostrare che tutto è possibile. Inventa per consentire alle persone di fare cose grandiose, come volare, telefonare, scrivere meglio, respirare. Lo fa perché ha una sorta di dono che interpreta come un dovere, quasi avesse fatto uno sgarbo al mondo e si sentisse in dovere di farsi perdonare.